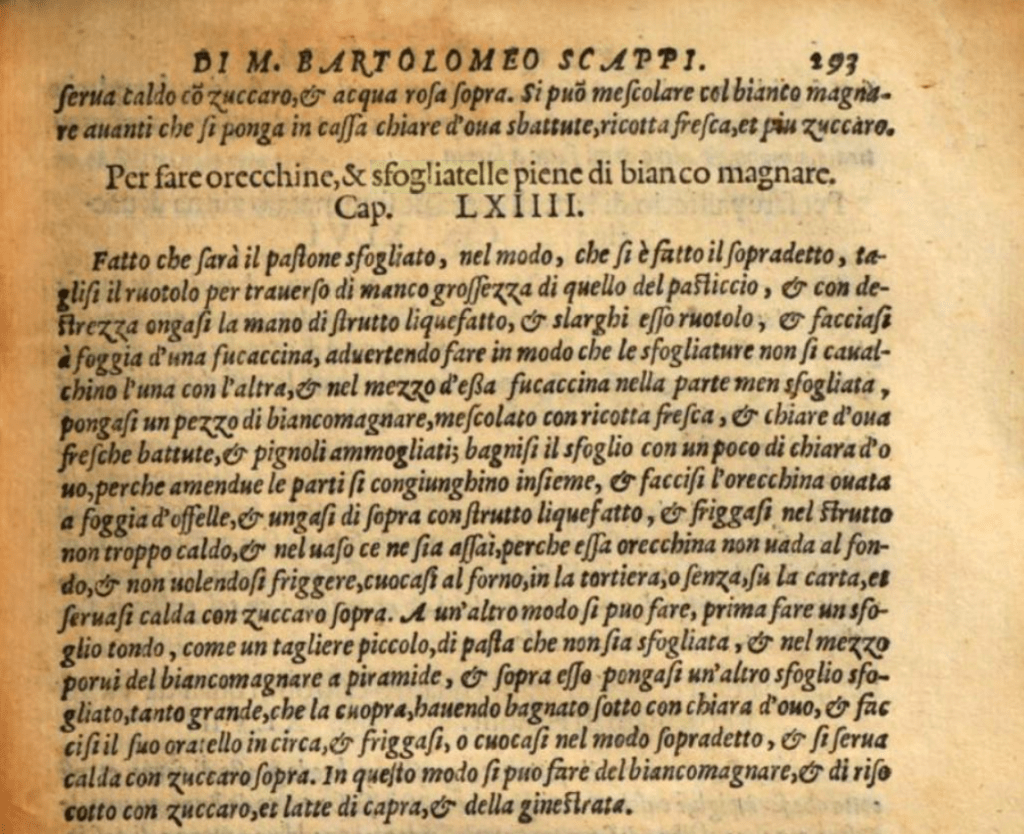Angelo Forgione – La sfogliatella, delizia tra tante della pasticceria napoletana, altro simbolo della città di Parthenope in duplice versione – La riccia, la più antica – di cui sono assai incerte le origini. Una tradizione la vuole nata alla fine del XVIII secolo nel monastero napoletano della Croce di Lucca dalla creatività di una dama ai voti o da un’addetta alla realizzazione di dolci. Un’altra la vuole inventata nel XVII nel convento di Santa Rosa a Conca dei Marini, in Costiera amalfitana.
Pare proprio che la Santa Rosa, diversa della più nota sfogliatella per la presenza di crema pasticciera e amarene sulla sommità, per l’uso delle uova nell’impasto della sfoglia e per maggiore grandezza, sia antecedente, e pare anche che avesse forma di un cappuccio, un sorta di cono rovesciato. Si narra che a modificarlo sia stato Pasquale Pintauro, a Toledo, nel primo Ottocento, conferendovii l’attuale forma di conchiglia e sdoganandola con gran fortuna.
E qui si arrestano tradizioni e racconti, e si parte con i documenti, perché qualcosa di assolutamente accertato è che una sfogliatella antesignana esisteva già in epoca medievale, e non è detto affatto che si trattasse di roba partorita nella Napoli angioina o aragonese. Il primo riferimento scritto è datato 1529, e ce l’offre Cristoforo Messisbugo, cuciniere alla corte di Beatrice d’Este e dei Gonzaga di Mantova, nel suo trattato Libro novo nel qual s’insegna a far d’ogni sorte di vivanda, in cui si legge di “Sfogliatelle di pignuoli sgrostate, con formaggio grasso“.
Non basta questo ad affermare che per sfogliatella si intendesse pressappoco quel che si intende oggi, e di certo il contenuto era ben diverso, ma un riferimento più attendibile ce lo offre il lombardo Bartolomeo Scappi, cuoco papalino, nel suo trattato di cucina Opera di B. S. del 1570, in cui si legge di sfogliatelle diverse: “Sfogliatelle fatte con butiro, et pignoli ammaccati per dentro”; “Sfogliatelle, fatte con latte, butiro, rossi d’oua, e zuccaro”; “Sfogliatelle fatte con butiro e rossi d’oua”; “Sfogliatelle semplici, fatte con latte, et oua“; e poi la spiegazione della preparazione delle “Sfogliatelle piene di bianco magnare“, fatte con “pastone sfogliato” da richiudere “perché le amendue le parti si congiunghino insieme”. Il ripieno era così fatto: “un pezzo di biancomagnare, mescolato con ricotta fresca, e chiare d’oua (uova) fresche battute, i pignoli ammogliati”. Cos’era il “biancomagnare” (o biancomangiare)? Una preparazione d’epoca medievale molto diffusa e diversificata. In questo caso, lo Scappi spiega nella ricetta precedente trattarsi di un pasticcio bianco rassodato fatto con farina, rossi d’uova, strutto, sale, zucchero e acqua di rose. La sfogliatella andava poi fritta nello strutto caldo o cotta in forno, per poi servirla “calda con zuccaro sopra”. Altra maniera poteva essere quella di non usare la “pasta sfogliata” ma “un sfoglio tondo” su cui porre al centro il ripieno “a piramide, e sopra esso pongasi un’altro sfoglio sfogliato, tanto grande che la cuopra”.
Tutto divulgato nel 1570 da un cuciniere lombardo, che non è da confondersi con l’inventore di un dolce di cui non si conosce la paternità ma che sicuramente è stato sublimato in Campania con un ripieno di semolino, ricotta, zucchero, uova, scorzetta d’arancia, cannella, vaniglia e aromi vari, divenuto uno degli emblemi della rinomatissima e deliziosissima pasticceria napoletana.
La preparazione dell’impasto, ottenuto con farina americana, sale, acqua e sugna, è estremamente complessa e richiede l’esperienza di un pasticcere, dal momento che la sottile sfoglia ottenuta va arrotolata più volte fino a costituire un cilindro di trenta centimetri di lunghezza e otto di diametro che, una volta conservato in frigorifero per 24 ore, può essere tagliato a fette per ottenere i cosiddetti “tappi”, da “aprire” in modo da ottenere delle coppette che accoglgano il ripieno. L’impasto della frolla è certamente più semplice da realizzare, ma non meno delizioso per chi preferisce la friabilità alla croccantezza.