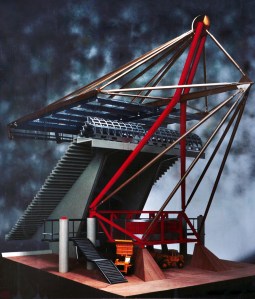Angelo Forgione – Due scudetti in tre anni. Investimenti importanti, a partire da quello per Antonio Conte, e una presenza dominante sul mercato di rafforzamento dei club di Serie A. È la rivoluzione copernicana del calcio di Aurelio De Laurentiis, di fatto la rivoluzione aureliana, che ha cambiato le certezze e invertito le polarità economiche, portando un club del Sud Italia a trainare il calcio italiano per la prima volta da quando, nel 1926, cioè un secolo fa, ai club meridionali è stata data la possibilità di misurarsi direttamente con quelli settentrionali.
Ma come ci è riuscito un uomo che veniva dal mondo in declino del cinema e che ha pensato bene di riciclarsi nel mondo dorato del calcio, di cui non conosceva nulla? Irrotto sul palcoscenico del pallone nel 2004, ha imparato velocemente e lo ha piegato alle sue regole, fino a rivoluzionarlo. Ha issato un club finito in tribunale e nei campi di Serie C fino al trono d’Italia, e lo ha fatto attuando un modello di calcio imprenditoriale, una visione prospettica che gli ha consentito di far fruttare quanto messo insieme in 20 anni, arco di tempo in cui la tendenza del margine operativo lordo del club, cioè della differenza tra ricavi e costi, risulta decisamente positiva.
4 miliardi di ricavi e un utile aggregato superiore ai 100 milioni (fonte: Calcio e Finanza) nell’arco del ventennio aureliano. Non sono certamente tali cifre ad aver fatto la differenza, poiché il fatturato strutturale (introiti dai diritti tv, sponsor, bigliettazione stadio, merchandising e ricavi commerciali) della SSC Napoli, quantunque in progressiva crescita, è ancora inferiore a quello di Inter, Milan e Juventus.

La differenza, il Napoli, la fa per un motivo assai banale, se pensiamo che si tratta pur sempre di un’azienda: l’assenza di debiti. Elemento figlio della sostenibilità economica, cioè di un attento controllo dei costi. Grazie a un oculato player trading, cioè alla strategia di acquisto, valorizzazione e vendita dei calciatori, il Napoli ha generato forti plusvalenze negli anni, reinvestite per sostenere la sua crescita e rigenerare i suoi cicli. Oltre il 95% delle risorse finanziarie prodotte è stata investita in calciatori.
De Laurentiis non si è accontentato di una mediocrità di risultati, ma ha badato prima alla sostenibilità del club e poi ai trofei; non ha sacrificato i conti per inseguire le vittorie, come hanno fatto le altre tre big, quelle del Nord, incastrate in un’esasperata competizione storica non solo calcistica tra Milano e Torino. De Laurentiis, fuori da questa dinamica perversa per questioni geografiche e storiche, ha evitato bellamente ogni rincorsa ossessiva al trionfo ma ha lavorato con lungimiranza per arrivarci senza affanno e con fiato lungo. Ha atteso con pazienza il momento per far valere una solidità economica costruita anno dopo anno. Il momento è arrivato quando ci si è messi alle spalle la forte crisi del calcio generata dalla pandemia da Covid-19, che ha colpito naturalmente anche il Napoli, ma, grazie alla sua solidità, non alla stessa maniera delle concorrenti.
Tra le stagioni 2019/20 e 2021/22, anche per il club partenopeo tre bilanci in rosso, ma zavorrati più da due mancate qualificazioni in Champions League consecutive (2020 e nel 2021) che dall’emergenza sanitaria. Eppure De Laurentiis ne è venuto fuori bene e ha colto l’occasione per svettare.
Basta osservare il grafico dei risultati netti dei quattro top club della Serie A negli ultimi 10 anni, ovvero ciò che è rimasto in cassa o che si è accumulato a debito nei bilanci annuali di Napoli, Milan, Inter e Juventus, per dedurre che il club azzurro è uscito dalla crisi pandemica molto meglio delle altre big, capaci di fatturare di più ma enormemente indebitate e gravate da costi superiori, tra cui quelli di riduzione dei rispettivi deficit.
Tra l’esercizio del 2020 e quello del 2022, i risultati netti del Napoli hanno prodotto un passivo di -129,7 milioni. Passivo comunque decisamente inferiore ai quelli di -357,5 milioni del Milan, -488 dell’Inter e -553,9 della Juventus. Peraltro, il club azzurro, prima della pandemia, aveva fatto segnare alcuni attivi di bilancio, diversamente da Milan e Inter, che avevano accumulato debiti enormi, e dalla Juventus, che a partire dall’acquisto di Cristiano Ronaldo aveva infilato due passivi importanti (-59,2 miliardi in totale). L’azzardo di Andrea Agnelli, nel tentativo di vincere una Champions per incrementare i ricavi e il blasone, non poteva permettersi imprevisti, come quello che poi sopraggiunse al secondo anno di CR7.
La Juventus si è ritrovata a perdere 553,9 milioni tra il 2020 e il 2022, dovendo provvedere a diversi aumenti di capitale per un totale di 700 milioni e a ricche sponsorizzazioni della casa madre Exor, e provando inutilmente e illecitamente a limitare i danni con plusvalenze fittizie e scorrette manovre stipendi, colpite dalla scure della magistratura ordinaria e di quella sportiva, con anche una penalizzazione di dieci punti in classifica nel campionato 2022/23 e la dannosissima esclusione dalle competizioni europee.
L’Inter ha dovuto far fronte a un rosso complessivo di circa 488 milioni accumulato nel triennio 2020-2022. Nella fase di contrazione dovuta al Covid, anche la presenza di Antonio Conte nell’area tecnica ha fatto sentire il suo impatto sui costi. La proprietà di allora, Suning, ha dovuto limitare al minimo il proprio apporto, aggravando il livello di indebitamento e i connessi oneri finanziari. Da qui l’impossibilità di rimborsare un debito di 395 milioni di euro contratto con il fondo statunitense Oaktree Capital Management e di mantenere la proprietà.
Un po’ meno scura la situazione del Milan, che dall’ingresso di Elliot ha iniziato a ridurre il passivo. Il club rossonero, nel triennio 2020-2022, ha fatto registrare un calo del deficit, comunque pari a 357,5 milioni.
Nell’estate del 2022, i quattro top club hanno adottato politiche di contenimento dei costi, in linea con le esigenze di sostenibilità finanziaria post-Covid, e hanno ridotto i rispettivi monte ingaggi. Il club di De Laurentiis è quello che ha effettuato il taglio più significativo, con una diminuzione del 27%. Ceduti uomini di vecchia militanza come Mertens, Koulibaly, Insigne, ma anche Ospina, Ghoulam e Manolas, svecchiando la rosa e mettendo dentro elementi come Kvaratskhelia, Kim e Raspadori. Nonostante la forte contestazione del tifo napoletano per la perdita di elementi a cui era affezionato, la manovra ha prodotto ottimi frutti: il Napoli ha coniugato il contenimento dei costi con la competitività, arrivando persino alla vittoria dello scudetto 2022/23 e al conseguimento dell’utile più alto della storia della Serie A: +79,7 milioni. Scudetto in campo e fuori. Così, in quel momento, il Napoli ha iniziato a fare la differenza con le altre big.

E però, dopo la vittoria del campionato 2022/23, De Laurentiis ha sbagliato la gestione del trionfo e ha inanellato tutta una serie di scelte sbagliate ed enormi errori gestionali che hanno condannato il Napoli a una stagione disastrosa, culminata con un decimo posto e la dannosa esclusione dalle coppe europee dopo quindici anni di presenza continua.
Ma il patron azzurro non è rimasto vittima di se stesso e non ha affatto tirato i remi in barca; anzi, ha dato fondo alle riserve auree – al 30 giugno 2024, il patrimonio netto del club era di 211,5 milioni – e ha rilanciato, ingaggiando nientemeno che l’impegnativo Antonio Conte (con il suo folto staff) e investendo anche 150 milioni sul mercato per ingaggiare Lukaku, McTominay, Neres e Buongiorno. Il nuovo allenatore ha dettato al Presidente un cambio di paradigma rispetto al passato: gli investimenti hanno raggiunto il picco massimo e sono stati impegnati per calciatori con un’età media in rialzo di quasi due anni rispetto alla squadra che aveva vinto lo scudetto un anno prima. Il monte ingaggi è cresciuto a 82 milioni, ma è rimasto comunque di 59 milioni più basso di quello dell’Inter (141), 26 di quello della Juventus (108) e 22 di quello del Milan (104), e anche inferiore a quello della Roma (89). Risultato? Il Napoli, con il quinto monte ingaggi della Serie A, al culmine della stagione di ricostruzione, è tornato immediatamente ad acciuffare il trofeo dello scudetto, il secondo in tre anni.
Il fatto è che De Laurentiis, con la sua politica gestionale, ha messo il Napoli in condizione di poter ben ammortizzare le cadute e rialzarsi in piedi. È accaduto dopo il Covid e le due assenze consecutive dalla Champions League, ed è accaduto dopo il decimo posto. È accaduto nel periodo più nero per il calcio, quello in cui i tonfi sono costati caro alla Juventus, e non solo alla Juventus, ma non al Napoli.
È prevedibile che, per lo sforzo economico profuso per riportare immediatamente il Napoli al vertice e per i mancati introiti UEFA, il bilancio 2024/25 della SSC Napoli si chiuda in negativo, ma il ritorno in una Champions League più remunerativa, la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, nonché quella di Osimhen al Galatasaray (alle condizioni perentorie dettate da De Laurentiis) e il premio scudetto consentiranno di ammortizzare gli esborsi fatti per ripartire dopo il decimo posto, ma anche di sostenere l’aumento del monte ingaggi per il rafforzamento imposto da Antonio Conte.
Ed ecco che il Napoli di oggi, dopo aver trattenuto il gravoso allenatore con la promessa di esaudirne le esigenti richieste, fa la voce grossa sul mercato con un budget tra i 150 e i 200 milioni.
La bontà della gestione De Laurentiis e la forza della società azzurra è evincibile da un dato eloquente: considerando gli utili degli ultimi dieci anni, alcuni dei quali fortemente condizionati dalla pandemia, il Napoli è l’unico club che fa segnare il segno positivo: +118,8 milioni. Stratosfera, soprattutto se si confronta il dato con quelli in passivo di -816,1 del Milan, di -832,8 dell’Inter e di -888,1 della Juventus.
Ed è il club in testa alla classifica europea dei club più sostenibili sotto il profilo finanziario secondo l’ultimo rapporto pubblicato da Off The Pitch, aggiornato a giugno 2025, che ha analizzato indicatori fondamentali quali ricavi operativi, contenimento dei costi salariali, equilibrio patrimoniale e capacità di generare utili re-investibili nel medio-lungo periodo. Un club che ha saputo coniugare forza delle finanze e forza della squadra, introiti e vittorie.
In conclusione, si può serenamente affermare che il Napoli, per meriti propri, ha paradossalmente beneficiato della crisi pandemica del calcio. Pur essendo ancora un club dimensionalmente inferiore a Juventus, Milan e Inter, è diventato leader in tutti i parametri economico-finanziari, finendo per insegnare ai competitor la strada della sostenibilità quale condizione necessaria per il conseguimento del risultato sportivo, e non viceversa.
Conti in ordine, esborsi mediamente inferiore agli incassi, produttivo reinvestimento delle plusvalenze da player trading, capacità di affrontare gli insuccessi e resilienza. Così si è compiuta la rivoluzione aureliana.



 Angelo Forgione – La lezione di calcio che il Napoli ha restituito alla Juventus dice che la diffenza in classifica tra le due squadre è falsa, ma intanto c’è, e le colpe sono tutte del Napoli, che non riesce ad essere affamato con le “piccole” come gli avversari. Inutile dunque spostare il dibattito in economia sportiva. Benitez ha parlato di fatturati juventini e Conte di investimenti napoletani. La verità è che l’ultimo saldo delle entrate dice 275 milioni per la Juventus e 125 per il Napoli, che è l’unica squadra della Serie A ad essere autosufficiente, ovvero a non dover ricorrere alle banche e alla proprietà. Ed è verissimo che il Napoli sia la società ad aver investito maggiormente nel mercato 2013/14, con esborsi per 100.700.000 €, ma ciò è stato possibile solo grazie alle continue plusvalenze degli ultimi anni, ultima la cessione di Edinson Cavani al PSG (+52.500.000 €), terza miglior plusvalenza in assoluto della storia. Insomma, il Napoli è più virtuoso e la Juventus è più ricca. Stop!
Angelo Forgione – La lezione di calcio che il Napoli ha restituito alla Juventus dice che la diffenza in classifica tra le due squadre è falsa, ma intanto c’è, e le colpe sono tutte del Napoli, che non riesce ad essere affamato con le “piccole” come gli avversari. Inutile dunque spostare il dibattito in economia sportiva. Benitez ha parlato di fatturati juventini e Conte di investimenti napoletani. La verità è che l’ultimo saldo delle entrate dice 275 milioni per la Juventus e 125 per il Napoli, che è l’unica squadra della Serie A ad essere autosufficiente, ovvero a non dover ricorrere alle banche e alla proprietà. Ed è verissimo che il Napoli sia la società ad aver investito maggiormente nel mercato 2013/14, con esborsi per 100.700.000 €, ma ciò è stato possibile solo grazie alle continue plusvalenze degli ultimi anni, ultima la cessione di Edinson Cavani al PSG (+52.500.000 €), terza miglior plusvalenza in assoluto della storia. Insomma, il Napoli è più virtuoso e la Juventus è più ricca. Stop!