nuovo schiaffo dopo quello ai tempi del colera e quelli più recenti
 Angelo Forgione – La copertina de l’Espresso, dedicata all’inquinamento di Napoli, recita così: “Bevi Napoli e poi muori”. Da un rubinetto nero fuoriesce acqua nera, non caffè napoletano, e parte la psicosi del bicchier d’acqua. L’inchiesta rende noti i risultati di una ricerca del comando americano sul territorio eseguita tra il 2009 e il 2011, dalla quale si evincerebbero tracce di uranio nell’acqua contaminata e gas velenosi che escono dal suolo. I militari USA concludono: “Nessuna zona è sicura, nemmeno nel centro di Napoli”.
Angelo Forgione – La copertina de l’Espresso, dedicata all’inquinamento di Napoli, recita così: “Bevi Napoli e poi muori”. Da un rubinetto nero fuoriesce acqua nera, non caffè napoletano, e parte la psicosi del bicchier d’acqua. L’inchiesta rende noti i risultati di una ricerca del comando americano sul territorio eseguita tra il 2009 e il 2011, dalla quale si evincerebbero tracce di uranio nell’acqua contaminata e gas velenosi che escono dal suolo. I militari USA concludono: “Nessuna zona è sicura, nemmeno nel centro di Napoli”.
Di che acqua si tratta e di quali aree? Quelle tra Napoli e Caserta: tre “zone rosse” intorno a Casal di Principe, Villa Literno, Marcianise, Casoria e Arzano, dove i militari presero in fitto appartamenti abusivi e quindi allacciati a pozzi contaminati, e non dalla rete idrica. Criticità sono segnalate anche per il 57 per cento degli acquedotti esaminati nel centro di Napoli e il 16 per cento nel quartiere Bagnoli, non a causa delle sorgenti ma per via delle cattive condizioni delle tubature, e qui il problema è diverso.
Non è il caso di mettere la testa sotto la sabbia perché un grosso problema ambientale c’è, ma bisogna chiarire che le analisi americane erano riferite ad acqua “illegale” e su queste il quotidiano ha calcato la mano, strumentalizzando dati che con la rete idrica niente c’entrano. L’acqua erogata in città, almeno quella, risulta controllata e potabile, e i dati delle analisi sono consultabili da tutti attraverso il sito dell’azienda ABC, che quindici mesi fa, ben oltre il 2011, quando si chiamava Arin, fu elogiata da SKY che informò gli italiani sul fatto che l’acqua più “trasparente” del Paese fosse quella di Napoli. “Il servizio porta Napoli  tra le eccellenze per quanto riguarda la ‘trasparenza’ e la assiduità della comunicazione pubblica dei dati a proposito delle acque che circolano nella rete idrica cittadina”. Questa fu la notizia che nel dettaglio esaltava i ventotto parametri tenuti in considerazione dalle analisi di laboratorio, i cinquantuno punti di prelievo e gli aggiornamenti pubblici a cadenza mensile, quartiere per quartiere. Meglio della pur esaustiva municipalizzata Smat di Torino e di tutte le altre città italiane. Presi per buoni i valori pubblicati, tutti soddisfacenti, ognuno può verificare, almeno nella città di Napoli, cosa beve.
tra le eccellenze per quanto riguarda la ‘trasparenza’ e la assiduità della comunicazione pubblica dei dati a proposito delle acque che circolano nella rete idrica cittadina”. Questa fu la notizia che nel dettaglio esaltava i ventotto parametri tenuti in considerazione dalle analisi di laboratorio, i cinquantuno punti di prelievo e gli aggiornamenti pubblici a cadenza mensile, quartiere per quartiere. Meglio della pur esaustiva municipalizzata Smat di Torino e di tutte le altre città italiane. Presi per buoni i valori pubblicati, tutti soddisfacenti, ognuno può verificare, almeno nella città di Napoli, cosa beve.
 A fine 2011, un altro studio interuniversitario aveva analizzato la qualità di 157 campioni raccolti in casa o alle fontanelle di oltre un centinaio di località del Nord, del Centro e del Sud della Penisola. Fu realizzato nell’ambito del progetto europeo Eurogeosurvey geochemistry expert group con il lavoro di alcuni ricercatori italiani, grazie ai quali fu possibile valutare l’acqua di 112 comuni. In 5 casi l’acqua analizzata non risultò potabile e tra le dieci città con maggiore concentrazione di nitrati non figurava Napoli ma, ad esempio, città come Milano e Venezia.
A fine 2011, un altro studio interuniversitario aveva analizzato la qualità di 157 campioni raccolti in casa o alle fontanelle di oltre un centinaio di località del Nord, del Centro e del Sud della Penisola. Fu realizzato nell’ambito del progetto europeo Eurogeosurvey geochemistry expert group con il lavoro di alcuni ricercatori italiani, grazie ai quali fu possibile valutare l’acqua di 112 comuni. In 5 casi l’acqua analizzata non risultò potabile e tra le dieci città con maggiore concentrazione di nitrati non figurava Napoli ma, ad esempio, città come Milano e Venezia.
Bisogna pretendere chiarezza dall’indagine dei militari  USA e da chi deve sovraintendere alla salute pubblica, ma una cosa è certa: non è la prima volta che il settimanale l’Espresso sbatte il mostro Napoli in prima pagina. Passando per il “Napoli addio” del 2005 e il “Napoli perduta” del 2006, sembra di rivivere i tempi del colera del 1973, quando Napoli fu colpita dall’accanimento mediatico e da titoli a sensazione, salvo poi scoprire che l’epidemia fu portata da mitili del Nordafrica. Anche in quell’occasione, l’Espresso titolò addirittura “Bandiera gialla”. Ne era inviato un giovane Paolo Mieli, che, conoscendo certe dinamiche, riconosce oggi quanti ricami giornalisti si facciano su Napoli.
USA e da chi deve sovraintendere alla salute pubblica, ma una cosa è certa: non è la prima volta che il settimanale l’Espresso sbatte il mostro Napoli in prima pagina. Passando per il “Napoli addio” del 2005 e il “Napoli perduta” del 2006, sembra di rivivere i tempi del colera del 1973, quando Napoli fu colpita dall’accanimento mediatico e da titoli a sensazione, salvo poi scoprire che l’epidemia fu portata da mitili del Nordafrica. Anche in quell’occasione, l’Espresso titolò addirittura “Bandiera gialla”. Ne era inviato un giovane Paolo Mieli, che, conoscendo certe dinamiche, riconosce oggi quanti ricami giornalisti si facciano su Napoli.
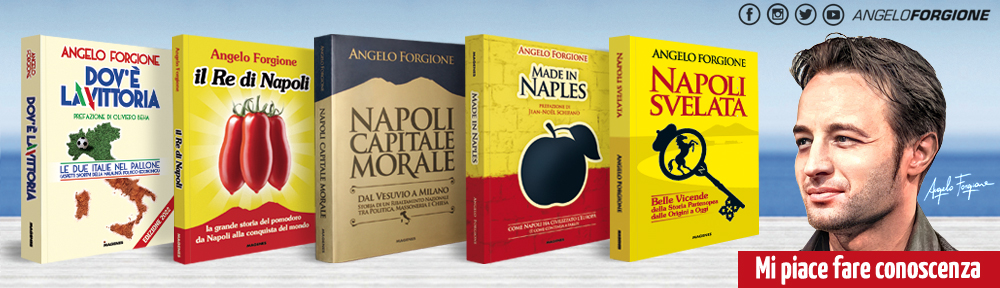
 Domenica 25 agosto andrà in onda una puntata di “Speciale Tg1” che rivisiterà i drammatici eventi del colera a Napoli del 1973, a quarant’anni dall’epidemia che colpì non solo la città partenopea ma anche altre città del bacino del Mediterraneo.
Domenica 25 agosto andrà in onda una puntata di “Speciale Tg1” che rivisiterà i drammatici eventi del colera a Napoli del 1973, a quarant’anni dall’epidemia che colpì non solo la città partenopea ma anche altre città del bacino del Mediterraneo. I media dell’epoca alterarono la realtà, consegnandola al pregiudizio, rompendo le ossa all’immagine della città. Solo quando dopo trenta giorni a Napoli tutto finì fu reso noto che il vibrione era nelle cozze tunisine. Nessuno però descrisse più l’epidemia che perdurava altrove, mentre Napoli si ritrovò orfana di turisti, ormai convinti che fosse una Calcutta italiana. Negli stadi d’Italia, luogo di crescente calciocentrismo nazionale, il Napoli di Vinicio fu da allora accolto al grido di “colera”, e fu proprio in quel momento storico che nacque quel coro/slogan razzista ancora ben radicato e mai contrastato dagli ipocriti organi preposti al contrasto dei fenomeni razziali negli impianti sportivi. Baresi, palermitani, cagliaritani e catalani non sono apostrofati come “colerosi”, e neanche i tifosi delle squadre di Milano, Genova, Torino, Verona, Treviso, Venezia, Trieste, Parma, Modena, Como, Bergamo, Brescia e altre città del Nord non bagnato dal mare ma colpite nell’Ottocento da diverse pandemie di colera per le scarse condizioni igieniche e non per delle cozze importate.
I media dell’epoca alterarono la realtà, consegnandola al pregiudizio, rompendo le ossa all’immagine della città. Solo quando dopo trenta giorni a Napoli tutto finì fu reso noto che il vibrione era nelle cozze tunisine. Nessuno però descrisse più l’epidemia che perdurava altrove, mentre Napoli si ritrovò orfana di turisti, ormai convinti che fosse una Calcutta italiana. Negli stadi d’Italia, luogo di crescente calciocentrismo nazionale, il Napoli di Vinicio fu da allora accolto al grido di “colera”, e fu proprio in quel momento storico che nacque quel coro/slogan razzista ancora ben radicato e mai contrastato dagli ipocriti organi preposti al contrasto dei fenomeni razziali negli impianti sportivi. Baresi, palermitani, cagliaritani e catalani non sono apostrofati come “colerosi”, e neanche i tifosi delle squadre di Milano, Genova, Torino, Verona, Treviso, Venezia, Trieste, Parma, Modena, Como, Bergamo, Brescia e altre città del Nord non bagnato dal mare ma colpite nell’Ottocento da diverse pandemie di colera per le scarse condizioni igieniche e non per delle cozze importate.