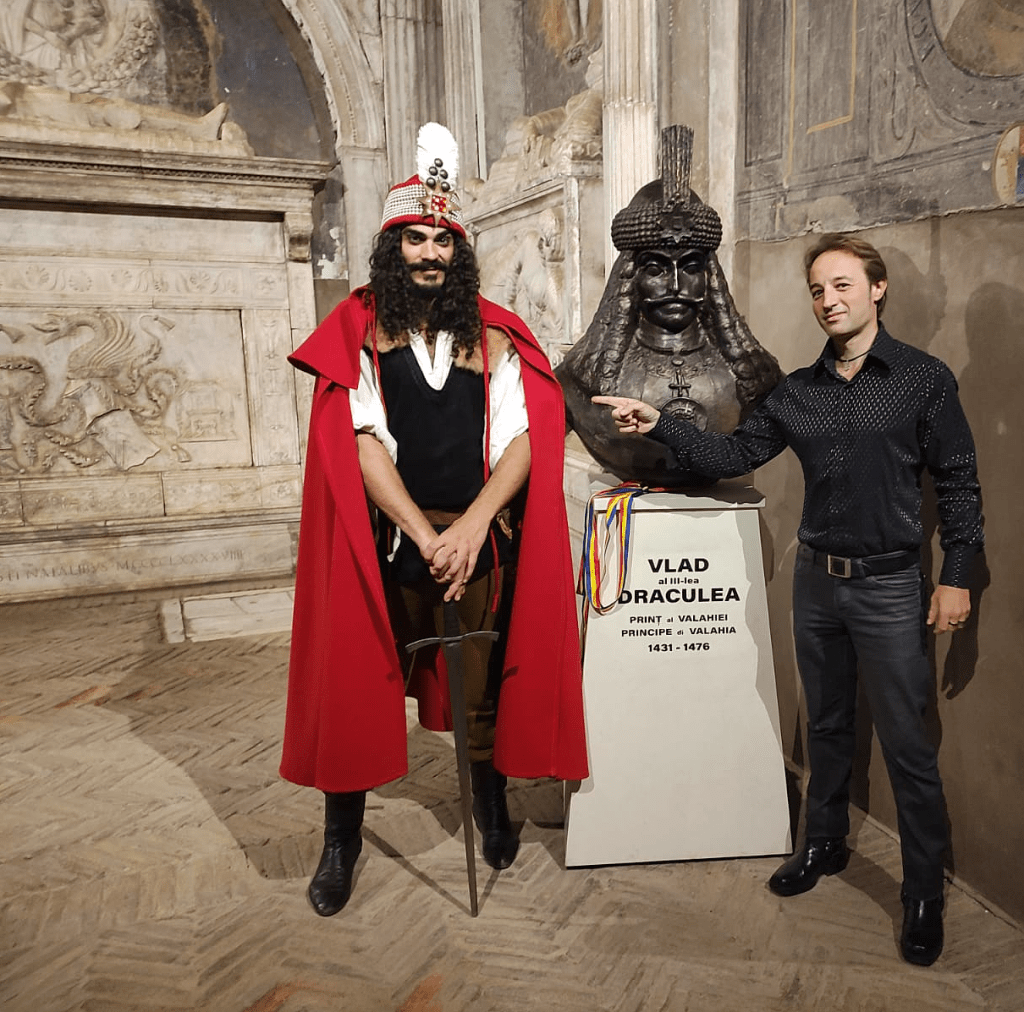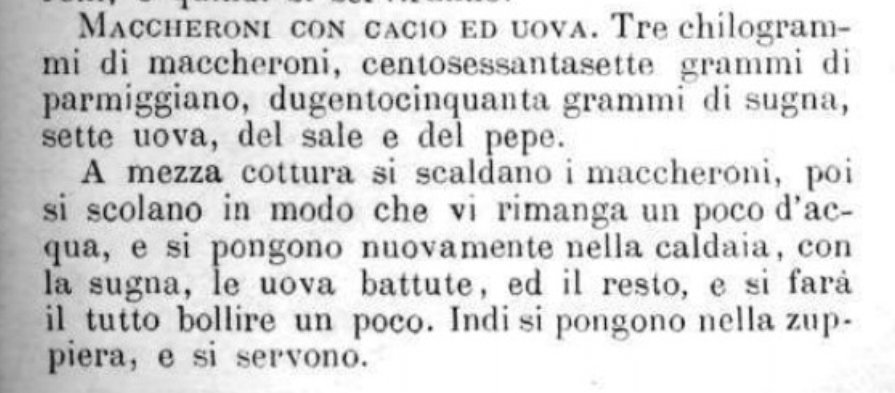Angelo Forgione — Qualcuno pur crede che Romeo e Giulietta, i due amanti simbolo dell’amore eterno, siano davvero esistiti nella bella Verona di un tempo, la stessa città che oggi, ogni giorno, accoglie migliaia di turisti assiepati nella strettoia di via Cappello che conduce a casa Capelletti, una dimora di pura fantasia in cui è fissato il dimicilio scaligero dell’archetipo universale dell’amore trascendentale nato altrove. Il suo parto, infatti, avvenne a Napoli, dalla penna del prosatore salernitano Tommaso Guardati, detto Masuccio Salernitano, nato probabilmente a Salerno nel 1410 e cresciuto letterariamente proprio all’ombra del Vesuvio, presso la splendente corte aragonese, dove fu stimolato da una vivace e raffinata cultura umanistica, frequentando uomini di spicco come Giovanni Pontano e Antonio Beccadelli.

Il Guardati fu autore, a metà del suo secolo, di una raccolta di novelle, poi pubblicata a Napoli nel 1476, un anno dopo la sua morte, con titolo Il Novellino. Tra i cinquanta racconti, scritti in lingua Volgare napoletana con influenze toscane, il trentatreesimo era la tragica storia d’amore di Giannozza e Mariotto, ispirata ai classici della letteratura greca.
La vicenda era ambientata nella Siena quattrocentesca, dacché da Siena proveniva l’uomo illustre cui era dedicata la novella: “a lo illustrissimo signor Duca d’Amalfi”. I due protagonisti, gli amanti Giannozza Saraceni e Mariotto Mignanelli, travolti dal fuoco della passione, si sposano in gran segreto. Poco dopo, Mariotto ha uno forte litigio in strada con un concittadino e finisce per ucciderlo. A causa di tale delitto viene condannato a morte e, per salvare la pelle, decide di fuggire ad Alessandria d’Egitto, presso uno zio. Giannozza non riesce a stargli lontano ed esegue un piano per raggiungerlo: si fa credere morta e, travestendosi da frate, grazie ad una falsa identità, si mette in viaggio per la città egiziana. Mariotto, informato dal fratello della morte della sua amata, decide di far ritorno a Siena. Nel frattempo, Giannozza giunge ad Alessandria d’Egitto e viene a conoscenza che Mariotto è rientrato in Italia. La donna decide dunque di rientrare anch’ella a Siena, laddove, una volta arrivata, apprende che il suo amato è stato scoperto dalle autorità e da poco giustiziato per l’omicidio commesso. Sconvolta dal dolore, la neovedova decide di chiudersi in convento, ma non sopravvive a lungo al suo profondo dolore e muore di crepacuore.
Mariotto senese, innamorato de Ganozza, como ad omicida se fugge in Alessandria [d’Egitto]; Ganozza se fenge morta, e, da sepultura tolta, va a trovare l’amante; dal quale sentita la soa morte, per morire anco lui, retorna a Siena, e, cognosciuto, è preso, e tagliatoli la testa; la donna nol trova in Alessandria, retorna a Siena, e trova l’amante decollato, e lei sopra ‘l suo corpo per dolore se more.
Tragedia ripresa sessant’anni più tardi, tra il 1512 e il 1524, dal vicentino Luigi Da Porto per una sua personale stesura con modifica di vicende e di nomi. Nella novella Historia nuovamente ritrovata di due nobili amanti, il prosatore veneto cambiò i nomi dei protagonisti. Non più Giannozza Saraceni e Mariotto Mignanelli ma Giulietta Capelletti e Romeo Montecchi. Diversa anche l’ambientazione, non più a Siena ma a Verona, città peraltro inquadrata nello scenario, descritto da Dante nella Divina Commedia, delle durissime faide familiari tra Guelfi o Ghibellini. Giulietta, figlia unica della ricca famiglia Capelletti, s’innamora perdutamente di Romeo Montecchi, rampollo della famiglia rivale. La ragazza è però data in sposa a Paride, un nobile altolocato, ma si rifiuta e, dopo alcune peripezie per affermare il suo amore per Romeo, pensando che egli sia morto, finisce per suicidarsi.
Novella in versione “scaligera” rielaborata poi dal tortonese Matteo Bandello, amico di Da Porto, e questa tradotta in inglese da Arthur Brooke nel 1562 (The tragical Historye of Romeus and Juliet). Versione britannica letta da William Shakespeare, che la drammatizzò in teatro alla fine del Cinquecento, affermando il mito di Giulietta e Romeo, le cui radici affondavano nella novella scritta un secolo e mezzo prima da Masuccio Salernitano alla corte di Napoli.
Luigi Da Porto aveva fatto inconsapevolmente uno sgarbo a Siena e un regalo a Verona, dove, negli anni Trenta del Novecento, si sarebbe data vita alle suggestioni shakespeariane inventando la casa di Giulietta, una finta dimora storica ricavata da una banale palazzina.
La scelta ricadde sul luogo dove risiedeva la famiglia Dal Cappello, antichi mercanti di spezie la cui proprietà era testimoniato dallo stemma — un cappello da Pellegrino — scolpito in rilievo sulla chiave di volta dell’arco interno del cortile dell’edificio. Qui fu portata una lastra gotica in pietra recuperata dal museo di Castelvecchio per creare un finto balconcino antico — la parola “balcone” non compare mai nelle prime scritture del dramma — al posto di una banale balconata con ringhiera. Un palazzo risistemato con elementi dal sapore medievale, anche all’interno. Un’operazione ideata da un lungimirante direttore museale e avallata dalla soprintendenza locale che, dal nulla, diede il via a una florida industria del turismo. Contemporaneamente fu creata ad arte anche la tomba della mai esistita Giulietta, inserita negli itinerari storici di Verona, utilizzando un sarcofago in marmo rosso, forse di età romana, posizionato nell’ex convento di San Francesco del Corso, appena fuori le mura cittadine, dentro le quali, il 16 settembre, si festeggia persino la fantasiosa data di nascita della ragazza suicida. Ogni giorno, invece, il cortile della casa di Giulietta, luogo divenuto il secondo sito più visitato di Verona dopo l’Arena (anche se il più deludente d’Italia, secondo alcuni dati). accoglie e raccoglie i sogni “ex-voto” degli innamorati sulle pareti dell’ingresso, mentre la statua di Giulietta, opera di Nereo Costantino del 1972, è venerata e toccata sui seni per propiziarsi l’amore eterno e indivisibile drammatizzato da William Shakespeare e narrato, per primo, da Tommaso Guardati.
.