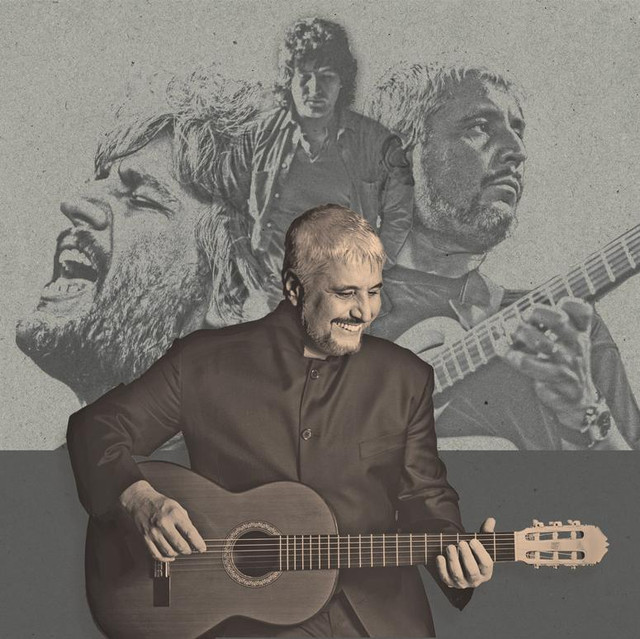Angelo Forgione – 4 gennaio 1825. Esattamente due secoli fa si spegneva Ferdinando di Borbone, il più longevo dei re italiani. Fu davvero un pessimo sovrano, rozzo donnaiolo perdigiorno e poco incline alle faccende politiche, come la tradizione risorgimentale ce l’ha presentato, o c’è dell’oltre da sapere?
Certo, l’approfondimento dello studio gli mancò, ma fu una scelta del suo precettore, il Principe di San Nicandro, consapevole che il quintogenito di Re Carlo, essendo di gracile costituzione in tenera età, dovesse rimediare a una salute malferma con attività motorie all’aperto. Caccia, Equitazione, Canottaggio e Pesca gli assicurarono un benefico e salutare irrobustimento, e continuò a praticarle anche da adulto. A tal proposito viene a noi una testimonianza firmata da Goethe, testimone diretto a Napoli, che ne descrisse senza pregiudizi la disciplina fisica nella biografia del pittore di corte Jakob Philipp Hackert:
“Fin dalla gioventù il Re era un cacciatore appassionato. Lo avevano educato alla caccia. Nei suoi verdi anni era stato delicato di salute. Fu l’esercizio della caccia a renderlo forte, sano e scattante. Hackert ebbe un giorno l’onore di essere invitato a caccia insieme con lui e con sorpresa vide che, su cento colpi, ne mancava solo uno. Non era solo la caccia, ma anche la vita all’aria aperta che lo manteneva in buona salute. Ciò che il Re ha imparato lo fa bene e con esattezza.
[…] Il Re sapeva remare come il più bravo dei marinai e si arrabbiava molto se i suoi compagni di remo non andavano al giusto ritmo. Tutto quello che sa, lo fa esattamente e se vuole apprendere qualcosa, non si dà pace fino a quando non l’ha imparato. […]”
Carente di istruzione, vero, ma a Ferdinando non fecero affatto difetto l’intuito per ingrandire la dimensione culturale di Napoli e la volontà di accrescerla artisticamente.
Gli incoraggiamenti all’arte concessi dal “Re lazzarone” furono enormi, e incontrarono convinti elogi nei vari territori italiani, tra cui quello del letterato lombardo Carlo Castone della Torre di Rezzonico, che in una corrispondenza di fine Settecento commentò la realizzazione della scultura Adone e Venere di Antonio Canova per il marchese napoletano Francesco Berio, per la quale Ferdinando concesse l’esenzione del dazio doganale per l’importazione dell’opera dallo Stato Pontificio:
“[…] non vi sarà discaro […] il sapere in qual pregio tengasi dall’illuminato governo un’opera sì bella, e quali facilità si concedano, e laudi, ed incoraggiamento a facoltosi personaggi, che con illustri monumenti cospirano a volgere quella deliziosissima capitale in un’Atene novella, avvegnacchè per quelli dell’antichità possa di già entrare in contesa coll’istessa Roma.”
Ferdinando esentò la ricca committenza privata napolitana dai dazi doganali affinché potessero lavorare a Napoli gli artisti residenti oltreconfine e arricchissero i nobili palazzi napoletani con importanti opere d’arte, proprio a partire da quelle di Canova, che lavorò anche per lo stesso sovrano e lo ritrasse in un’enorme statua per accogliere i visitatori del Real Museo, oggi il più importante archeologico d’Occidente e il primo realizzato nell’Europa continentale, voluto proprio dallo stesso Re nel secondo Settecento. Ma come? Un museo così importante voluto da uno zotico sovrano? Sì, lo zotico sovrano fu artefice dell’atto culturale più significativo del secondo Settecento facendo allestire proprio un museo in cui fece raggruppare tutti i tesori di famiglia, partendo dai preziosi reperti vesuviani, ai quali tolse la proprietà privata per donarli a Napoli e a tutti i suoi visitatori.
In quel museo vi fece trasferire anche le preziosità scultoree dei Farnese, ereditate dalla nonna Elisabetta insieme a quelle pittoriche e oggettistiche già raccolte a Capodimonte dal padre, Carlo di Borbone, prelevando le imponenti statue da Roma per farle giungere via Tevere e mare fino a Napoli, amplificando enormemente il richiamo della sua capitale e riconoscendole un insuperabile patrimonio classico, accresciuto negli anni. Chissà oggi dove sarebbe tutta quella ricchezza se egli non fosse stato così lungimirante come il padre.
Antonio Canova lo rappresentò proprio nelle vesti di Minerva, protettrice delle arti con l’elmo della saggezza in capo: allegoria in onore di un sovrano che, raggruppando le collezioni di Antichità, aveva lanciato l’immagine neoclassica di Napoli greco-romana, nuova Atene ma anche nuova Roma, veicolando il messaggio borbonico di protezione delle arti e della tutela dell’antico in una cornice, quale quella del prestigioso museo, che rappresentava il contributo decisivo di Napoli e dei Borbone, Carlo e Ferdinando, per la formazione della cultura classica in Europa e oltre. L’uno aveva stimolato l’archeologia e l’altro stimolava la raccolta artistica, assicurando gran prestigio internazionale a Napoli. Al padre, ben più magnificato del figlio, il merito enorme dei musei a cielo aperto, le città antiche riportate alla luce. Al figlio, quello di assegnare ai napoletani le collezioni di famiglia e di creare un museo che è ancora oggi il massimo riferimento culturale dell’antica capitale, l’esposizione di arte classica più bella e importante del mondo occidentale.
Da quel che si legge qua e là, parrebbe che il celebratissimo Carlo fosse ben più istruito del figlio, ma in realtà non lo fu affatto, ed era anche molto più superstizioso e bigotto di Ferdinando, che, pur essendo cattolico, superò le paure del tempo circa le prime immunizzazioni contro il terribile vaiolo, (altro che Covid!), fregandosene degli iniziali anatemi della Chiesa e dei rimproveri dello stesso cattolicissimo padre quando decise di sottoporre se stesso e la sua famiglia a un pioneristico e rischioso esperimento, la variolizzazione, al quale, dopo qualche anno, fece seguire l’avvio della prima vaccinazione di massa in Italia, resa obbligatoria per i bambini.
Il diplomatico milanese Giuseppe Gorani scrisse a fine Settecento nelle sue memorie così:
“Non solo Carlo III di Spagna non è più istruito del re di Napoli (Ferdinando), pur avendo ricevuta un’educazione meno cattiva, ma lo supera nei pregiudizi, e si rende ridicolo pretendendo d’essere sapiente”.
Carlo, nato altrove, si affezionò a Napoli profondamente, ma Ferdinando, napoletano di nascita e di spirito, ne fu anche più innamorato. Perciò non cancellò nulla di ciò che creò, neanche quando arrivarono gli invasori francesi, a differenza del padre, che non esitò a far distruggere la Real Fabbrica di Capodimonte prima di andarsene a Madrid per impedire proprio all’erede al trono partenopeo di proseguire le pregiate produzioni di porcellana, per poi scoprire che questi le aveva rimesse in piedi. Era lo stesso Carlo che aveva fatto sterminare i gatti di Procida, per impedire loro di attentare alla vita dei fagiani della riserva di caccia isolana, salvo poi dover fare marcia indietro di fronte alla rivolta dei procidani per la conseguente proliferazione di topi.
Ferdinando incentivò l’artigianato di qualità, a partire da quello serico di San Leucio, e fu inoltre vero stimolatore di una rivoluzione agricola di cui beneficiamo tutti noi oggi, tra produzione di pasta di grano duro, coltivazione di pomodoro lungo, lavorazione della mozzarella di bufala, protezione della vitivinicoltura e tanto altro ancora; e se le abitudini alimentari napoletane sono così peculiari e “nazionali” è perché egli fece da congiunzione tra quelle del popolo e dell’aristocrazia del suo tempo.
La verità è che Ferdinando fu decisivo quanto Carlo per la crescita del prestigio di Napoli e per la formazione della cultura classica in Europa e oltre. E se lo si racconta come non si fa per il padre è perché paga nella reputazione le teste fatte tagliare dopo la repressione della Repubblica partenopea del 1799. Avrebbe voluto concedere patti onorevoli di resa ed essere più clemente di quanto non fu la consorte Maria Carolina, assetata di vendetta nei confronti dei traditori che aveva portato a corte per il progresso civile di Napoli, pure rabbiosa per la sorte della carissima sorella Maria Antonietta, decapitata a Parigi. Fu la Regina a consentire all’ammiraglio inglese Horatio Nelson, inviato dal governo di Londra a salvaguardare gli interessi britannici in Sicilia, di decidere la sorte dei prigionieri in cambio di protezione del trono borbonico.
Dopo il tumultuoso periodo francese, a cavallo tra la Rivoluzione e gli sconvolgimenti napoleonici, l’ormai anziano Ferdinando rientrò a Napoli dall’esilio palermitano. Privo di risentimento, pensò solo a vivere l’ultima stagione della sua vita in serenità, finalmente nella sua città, libero dal peso della presenza di una consorte autoritaria e rasserenato da una nuova compagna docile e affettuosa, Lucia Migliaccio Contessa di Floridia, con la quale si rifugiò sulla collina del Vomero, in un’ovattata villa ad ella dedicata.
Prossimo alle 74 primavere e dopo 65 difficili anni di regno, si spense, non prima di aver fatto approntare la nuova piazza reale di Napoli e, in soli otto mesi, la ricostruzione della sala del Real Teatro San Carlo, assai più bella di quella fatta realizzare dal padre ottanta anni prima. Stendhal, milanese di adozione, la giudicò assai più bella della Scala, grazie alla volontà e alla determinazione di Ferdinando:
“La prima impressione è d’esser piovuti nel palazzo di un imperatore orientale. Gli occhi sono abbagliati, l’anima rapita. […] Non c’è nulla, in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la più pallida idea. […] Questa sala, ricostruita in trecento giorni, è come un colpo di Stato. Essa garantisce al Re, meglio della legge più perfetta, il favore popolare. […] Io stesso, quando penso alla meschinità e alla pudica povertà delle repubbliche che ho visitato, mi ritrovo completamente monarchico. […]”
Storiograficamente, Ferdinando non paga solo il sangue del 1799 ma anche la propensione al diletto e al dialetto, il fatto che fosse napoletano. Non era piemontese come Vittorio Emanuele II, vero zotico senza alcuna sensibilità artistica ma di esclusiva cultura militare sabauda, vero sovrano volgare e rozzo donnaiolo della prima Italia unita, i cui uomini fecero occultare la preziosa scultura di Canova sullo scalone del Museo Archeologico di Napoli. Tornò al suo posto solo nel 1997, per volontà di un impavido sovrintendente ai beni archeologici, Stefano De Caro, deciso a rendere giustizia tanto all’artista più celebrato tra fine Settecento e primo Ottocento, che a Napoli scoprì la devozione per l’Antico, quanto all’artefice iniziale del più grande e più importante contenitore di arte classica d’Occidente. E lo chiamano ancora “lazzarone”.