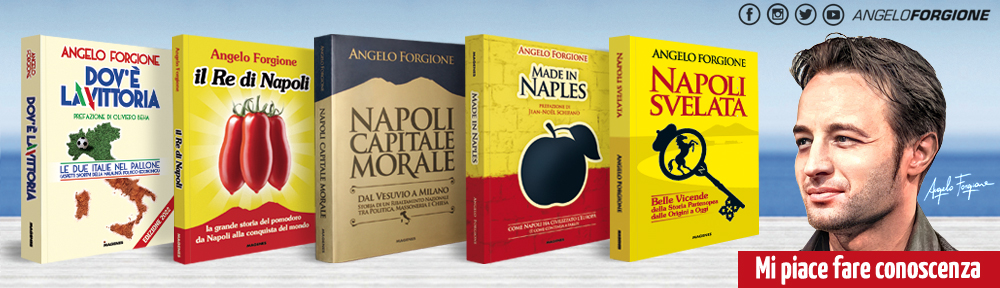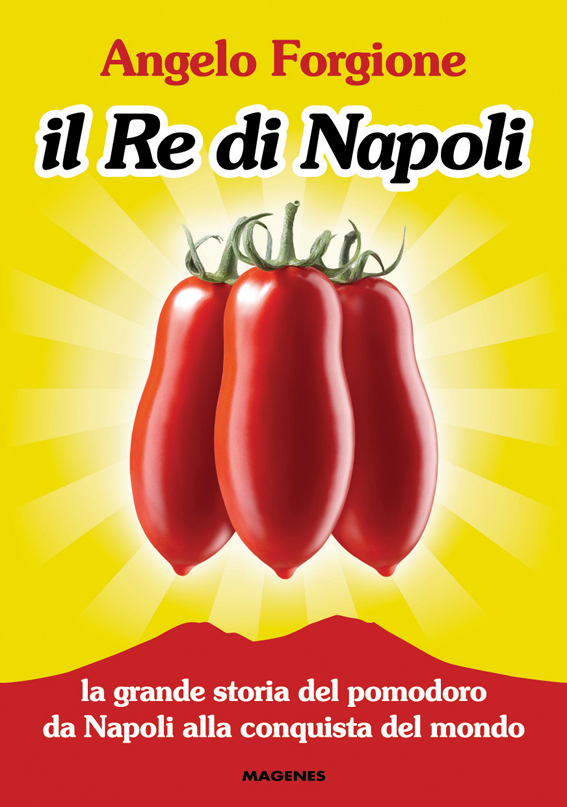Angelo Forgione — Chi meglio di Alfonso Pecoraro Scanio potevo allertare per arginare più incisivamente le inneffabili teorie di Alberto Grandi sulla pizza e non solo su quella? L’ex ministro delle politiche agricole, oggi presidente della Fondazione Univerde, è stato il promotore dell’Arte del Piazziuolo napoletano quale patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, e ha portato questo prestigioso risultato all’Italia e a Napoli. Era il più indicato per tutelare la pizza napoletana dalle sballate notizie storiche e dalle opinioni del professore mantovano di Scienza dell’alimentazione, alla ribalta con le sue narrazioni sulla storia e sull’evoluzione dei cibi italiani più rappresentativi, per lui riconducibili a origini e influenze americane più che italiane. Grandi, con l’intervista rilasciata al Financial Times, è tornato a far parlare di sé con più vigore dopo la ribalta conquistata lo scorso anno, attirandosi una tempesta di critiche da più fronti, ma pontificando sostanzialmente indisturbato.
Corrado Formigli ha ospitato entrambi a Piazzapulita (La7), e non è mancato un vivace botta e risposta su quanto di più antistorico ha dichiarato Grandi al Corriere della Sera:
«Finché è rimasta a Napoli, la pizza è stata una grandissima schifezza. Ma quando è arrivata a New York si è riempita di prodotti nuovi, in particolare della salsa di pomodoro, diventando la meraviglia che conosciamo oggi. Senza il viaggio degli italiani in America sono convinto che questa specialità sarebbe scomparsa».
Una “schifezza”, la pizza a Napoli, per il professore, finché, a inizio Novecento, non fu nobilitata negli Stati Uniti dal pomodoro. Smentito documentazione alla mano dal sottoscritto a mezzo stampa, in questi giorni come un anno fa, è dunque toccato farlo in tivù ad Alfonso Pecoraro Scanio, ben informato sul periodo storico in cui il pomodoro lungo è finito sulla pizza per la lettura del mio saggio Il Re di Napoli, in cui sono riportate tutte le documentazioni che attestano come la pizza con il pomodoro sia nata a Napoli nella prima metà dell’Ottocento, un secolo prima del periodo indicato dal professor Grandi (il primo Novecento newyorkese).
Lo scrive nel 1835 ne Le Corricolo Alexandre Dumas, probabilmente informato dal suo collaboratore napoletano, Pier Angelo Fiorentino, che il pomodoro è già sulla pizza in quel periodo:
“[…] La pizza è con l’olio, la pizza è con salame, la pizza è al lardo, la pizza è al formaggio, la pizza è al pomodoro, la pizza è con le acciughe. […]”.
Alberto Grandi ha sottolineato che «la salsa al pomodoro non è il pomodoro», facendone una questione di tipologia. Vien da chiedersi per il Nostro, e per Lorenzo Biagiarelli che nel dibattito ne condivideva l’obiezione, cosa finisca sulla pizza, oggi come due secoli fa, se non pomodoro lungo passato. E dunque, bene ha fatto Alfonso Pecoraro Scanio a reclamare con prontezza che i napoletani del primo Ottocento, con il pomodoro lungo, ci facevano banalmente la salsa passata. E mica ci voleva chissà quale scienza per schiacciarlo!
«Non erano degli imbecilli che non sapevano fare la salsa», l’opportuna riflessione dell’ex ministro. «La chiamavano “salsa alla spagnola”», ha replicato Grandi, scambiando la semplice salsa di pomodoro passato con un’altra più elaborata che a Napoli si preparava almeno dal secondo Seicento con pomodoro tondo. Ce ne dà testimonianza Antonio Latini ne Lo scalco alla moderna, overo l’arte di ben disporre i conviti, scritto e pubblicato a Napoli nel 1692, elencando la ricetta della “Salsa di Pomadoro, alla Spagnola”, fatta con pomodori (tondi), cipolle, peperoni, timo, sale, olio e aceto.
Due anni dopo la pubblicazione de Le Corricolo di Dumas, nel 1837, Ippolito Cavalcanti, incluse la ricetta dei “Vermicielli co le pommadore” nell’appendice dialettale Cucina casarinola all’uso nuosto napolitano del suo ampio trattato didattico Cucina teorico-pratica, e scrisse in vernacolo che bisognava far cuocere i pomodori, passarli e poi bollire “chella sauza” dopo aver fatto soffriggere olio e aglio.
Nello stesso trattato, il Cavalcanti elencava la “sauza de pommadore” tra gli ingredienti delle “Molignane a la Parmisciana”, la Parmigiana di melanzane.
Confusione tra salsa di pomodoro semplice ed elaborata, quella di Alberto Grandi, ma in ogni caso, va da sé che la salsa di pomodoro era già nelle conoscenze gastronomiche dei napoletani, e c’era già sulla pizza, come confermano pure i medici Achille Spatuzzi, Luigi Somma ed Errico De Renzi nella ricerca scientifica Sull’alimentazione del popolo minuto in Napoli, pubblicata nel 1863.
Crolla anche con il contributo di Grandi il teorema di Grandi, il quale ha pur sostenuto che la pizza napoletana, senza l’emigrazione in America, sarebbe scomparsa. Nella Napoli di inizio Novecento, mentre il primo napoletano faceva conoscere le pizze a New York (Gennaro Lombardi), si mangiava la pizza con il pomodoro da un secolo, e quella senza da almeno tre.
Le eresie del professore mantovano sono poi sfociate anche nell’argomento Dieta mediterranea:
«Ancel Keys – ha detto Grandi – ha scoperto alla fine della Seconda guerra mondiale che, rispetto agli americani, i napoletani non avevano colesterolo. Per forza, non mangiavano! Ci mancava anche che avessero il colesterolo».
«Forse mangiavano bene», ha ribattuto Pecoraro Scanio, anche in questo caso a giusta ragione.
Per il professore deve evidentemente valere la rappresentazione dei napoletani straccioni, gli unici nei quali poteva imbattersi Ancel Keys quando, nel 1952, si recò a Napoli con la moglie, la biologa Margaret Haney, per studiare l’alimentazione locale e la relativa incidenza sullo stato di salute dei cittadini una volta informato dal collega napoletano Gino Bergami della ridottissima incidenza delle patologie cardiovascolari nel capoluogo campano e dintorni. E invece il fisiologo americano, nei laboratori del Vecchio Policlinico, condusse le ricerche analizzando la salute e le abitudini alimentari dei Vigili del Fuoco e degli impiegati comunali, lavoratori stipendiati che il piatto a tavola lo portavano tranquillamente; e si recò nei mercati rionali per osservare cosa comprassero le massaie napoletane. Lo scienziato americano e la moglie rilevarono il basso consumo di carne e la dieta a base di pasta ricca di carboidrati, di verdure, di olio d’oliva, di pane, di legumi e di pesce, convincendosi che la riduzione dei grassi animali era alla base della buona salute dei napoletani. Al termine dei suoi studi, nei suoi appunti, Keys annotò:
“A Napoli la dieta comune era scarsa di carne e prodotti caseari, la pasta generalmente sostituiva la carne a cena. Nei mercati alimentari scoprii montagne di verdura e le buste della spesa delle donne erano cariche di verdura frondosa. Nello stesso tempo, i campioni di sangue degli uomini sotto controllo medico che noi stavamo visitando presentavano un basso livello di colesterolo. I pazienti con disturbi cardiaci alle coronarie erano rari negli ospedali e i medici locali ci dissero che gli attacchi di cuore alle coronarie non erano molto frequenti. I disturbi cardiaci alle coronarie erano ritenuti essere più comuni nelle classi benestanti dove la dieta era più ricca di carne e prodotti caseari. Mi convinsi che la dieta salutare era un motivo dell’assenza di disturbi cardiaci.
A Napoli trovammo la conferma che Bergami aveva ragione riguardo alla rarità della malattia ischemica coronarica nella popolazione generale, ma in ospedali privati che ricoveravano persone ricche vi erano pazienti con infarto al miocardio. La dieta della popolazione generale era ovviamente molto povera in carne e formaggi, e Margaret trovò livelli di colesterolo sierico molto bassi in numerose centinaia di operai e impiegati presi in esame dal Dott. Flaminio Fidanza, un assistente di Bergami nell’Istituto di Fisiologia. Fui invitato a cena con i membri del Rotary Club. La pasta era condita con sugo di carne e tutti la ricoprivano con formaggio Parmigiano. Un arrosto di carne era il secondo piatto. Il dessert era una scelta di gelato o ricchi dolci. Persuasi alcuni commensali a venire da me per essere esaminati, e Margaret trovò il loro livello di colesterolo molto più alto che negli operai.”
Del resto, prima di essere chiamati “mangiamaccheroni”, i napoletani erano detti i “mangiafoglia”, perché erano i più grandi vegetariani d’Europa da secoli. Già nel Quattrocento abbondavano i vegetali nella cucina della corte aragonese di Napoli, diversamente da quella toscana dei Medici, dove eccedevano carni e selvaggina. Il broccolo era stato lo stereotipo alimentare dei napoletani prima di pizza e spaghetti, che erano cibi popolari nati nelle strade e accessibili anche per i più poveri. Vincenzo Corrado, altra figura di spicco della cultura gastronomica napoletana, scrisse nel secondo Settecento Il cibo pitagorico (Pitagora fu un convinto vegetariano), primo ricettario vegetariano della storia, un elogio al cibo fatto “di tutto ciò che dalla terra si produce” contro la sofisticata e pesante cucina di carne.
Alberto Grandi ha pure avvisato che gli italiani di oggi credono essere antichissima una dieta, la “mediterranea”, che fu invenzione di Ancel Keys. La verità è che la codifica, non invenzione, del fisiologo statunitense, sviluppata nel Cilento, partì dall’alimentazione dei napoletani, e si rifece anche e soprattutto alla loro cucina. Da tempo la gente partenopea seguiva, senza saperlo, una dieta molto prossima a quella che è oggi è considerata la più sana ed equilibrata del pianeta. La dieta napoletana era davvero la madre di quella “mediterranea”. Era, ma non è, perché è stata proprio la penetrazione delle abitudini alimentari americane dagli anni del benessere economico italiano in poi, a seppellire la sana alimentazione del popolo partenopeo. la Dieta mediterranea, globalizzata dall’Unesco, è sempre meno applicata in Italia, dove i potentati del cibo spazzatura impongono i propri stili, soprattutto tra i giovani e le fasce con un basso livello socio-economico. Numerose indagini hanno infatti mostrato un aumento di sovrappeso e obesità, anche in età adolescenziale, e il fenomeno è più diffuso al Sud, proprio lì dove è nata la dieta mediterranea. E meno male che le narrazioni imprecise di Alberto Grandi esaltano esattamente le influenze americane nella cucina italiana tutta.