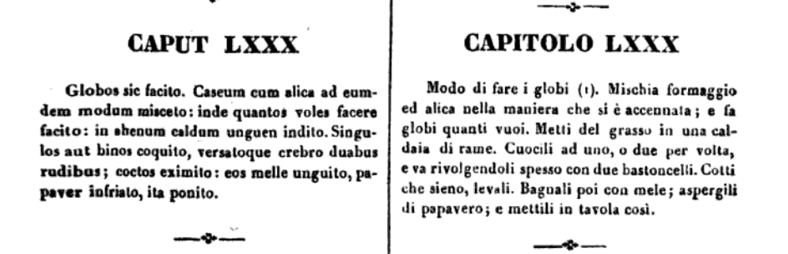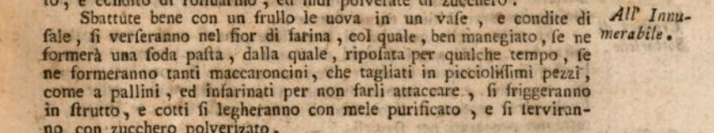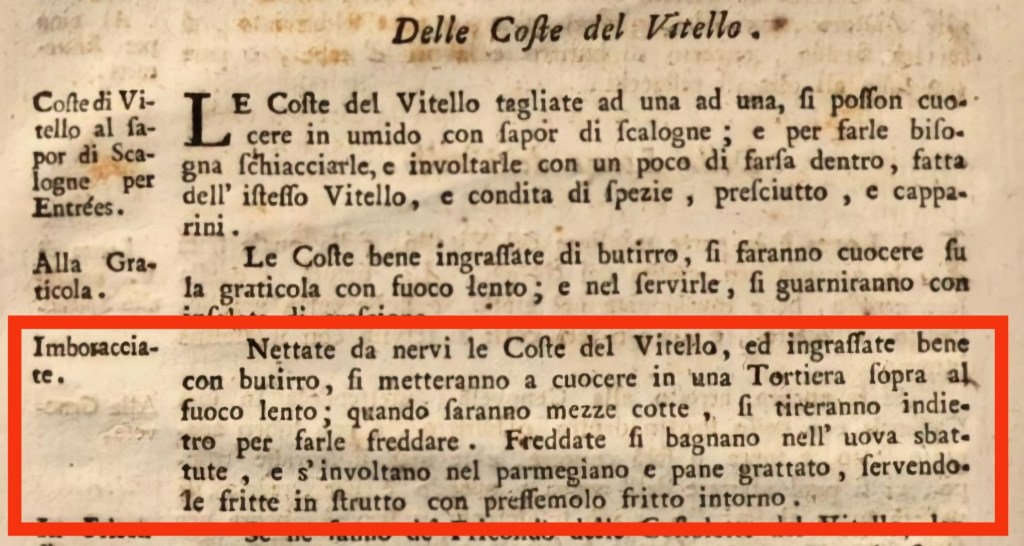Angelo Forgione – Ho letto con interesse l’articolo pubblicato stamane su Il Fatto Quotidiano online circa la genesi della pizza “margherita” (pomodoro e mozzarella), che secondo il professor Alberto Grandi, docente di storia dell’alimentazione all’Università di Parma, sarebbe nata in America.

Nell’articolo, di introduzione a un podcast di dodici puntate su spotify che pure ho ascoltato, il docente sostiene giustamente che “la pizza, fino al secolo scorso, la maggior parte degli italiani non sapeva neppure cosa fosse”, ma anche che “Quella che conosciamo e mangiamo anche oggi è nata in America e fino agli anni’50 gran parte degli italiani non la conosceva”.
Premetto che è giusto, tranne l’errore grave di attribuire la nascita della pizza con pomodoro e mozzarella agli americani.
Sostiene infatti il professor Grandi:
“Vero che la pizza è nata a Napoli ma si trattava di una pizza bianca, senza pomodoro e mozzarella, ricca di aglio e olio, mangiata per strada. Una sorta di street food primordiale”.
E ancora:
“Gli italiani imparano a fare la pizza con pomodoro e mozzarella negli Stati Uniti e poi, una volta tornati in Italia, portano con sé questo modo di prepararla che entra a far parte della nostra tradizione”.
L’errore enorme che commette Grandi è nel sostenere che la pizza con il pomodoro e la mozzarella nasca in America e la si impari a fare lì. Nel mio libro Il Re di Napoli, circa la storia del pomodoro, riporto le documentazioni che attestano come la pizza con il pomodoro e la mozzarella nasca indubitabilmente a Napoli nella prima metà dell’Ottocento.
È vero che la prima pizza dei napoletani, nel Seicento (così come le antiche preprazioni dei Greci e persino degli Egiziani) era bianca, poiché il pomodoro non era ancora abituale in alimentazione, e quello lungo ancora non era conosciuto in Europa. Intanto non era ricca di aglio e olio, come sostiene Grandi, ma di strutto, formaggio di pecora, pepe e basilico, e si chiamava “mastunicola”, nome derivante dalla storpiatura del lemma dialettale “vasinicola”, che in napoletano significa “basilico”.
Con l’inizio della coltivazione del pomodoro a bacca lunga attorno al Vesuvio, a fine Settecento, il cibo di strada del popolo napoletano iniziò a colorarsi di rosso. Quel pomodoro si chiamava “Fiascone di Napoli”, poi estintosi a metà del Novecento, quando era ormai stato sostituito dal “San Marzano”. L’uso del pomodoro su maccheroni e pizza inizia a diffondersi a inizio Ottocento, ed è attestato in numerosi scritti e ricettari.
Circa l’argomento in oggetto, è Alexandre Dumas a riportarne l’uso sulla caratteristica pizza nel suo Le Corricolo, scritto dopo aver visitato Napoli nel 1835 e pubblicato otto anni più tardi a Parigi:
“[…] La pizza è con l’olio, la pizza è con salame, la pizza è al lardo, la pizza è al formaggio, la pizza è al pomodoro, la pizza è con le acciughe. […]”.
Quasi tutte pizze “in bianco” quelle descritte dal romanziere francese, e una già “in rosso”, preparata soprattutto d’estate e d’autunno, perché il pomodoro era un prodotto molto più soggetto alla stagionalità di quanto non lo sia oggi, e lo si comprende da quello che si legge nella ricerca scientifica Sull’alimentazione del popolo minuto in Napoli, pubblicata nel 1863 dai medici Achille Spatuzzi, Luigi Somma ed Errico De Renzi:
“I Napoletani mangiano a dovizia le pizze: […] pizze condite alla superficie con olio o sugna in abbondanza, con formaggio, origano, aglio, prezzemolo, foglie di menta, con pomidoro specialmente in està, ed infine talvolta anche con piccoli pesciolini freschi. […] I pomidoro sono in Napoli adoperati moltissimo nell’està freschi, e nell’inverno o secchi o ridotti a conserva; […]”.
E la mozzarella? Insieme al pomodoro, ne fu stimolata la produzione nello stesso periodo, e insieme al pomodoro finì sulla pizza nella prima metà dell’Ottocento, a Napoli e non in America, a dispetto del romantico racconto riferito all’invenzione tricolore della pizza dedicata alla regina Margherita di Savoia datato 1889. Come più volte riportato in passato, lo attesta il filologo Emmanuele Rocco nel secondo volume dell’opera Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti, pubblicato nel 1858, scrivendo nel capitolo “Il pizzajuolo” che il trittico pomodoro-mozzarella-basilico era già una delle possibilità di condimento nelle strade di Napoli:
“La pizza non si trova nel vocabolario della Crusca, perché […] è una specialità dei napoletani, anzi della città di Napoli. […]
Le pizze più ordinarie, dette coll’aglio e oglio, han per condimento l’olio, e sopra vi si sparge, oltre il sale, l’origano e spicchi d’aglio trinciati minutamente. Altre sono coperte di formaggio grattugiato e condite collo strutto, e allora vi si pone disopra qualche foglia di basilico. Alle prime spesso si aggiunge del pesce minuto; alle seconde delle sottili fette di muzzarella. Talora si fa uso di prosciutto affettato, di pomidoro, di arselle ec. Talora ripiegando la pasta su di sé stessa se ne forma quel che chiamasi calzone.”
È evidente che nella complessità di quel periodo venivano sfornate anche pizze fatte con strutto, pomodoro, sottili fette di mozzarella, basilico e formaggio grattugiato. Basta sostituire l’olio allo strutto per avere proprio una margherita di metà Ottocento almeno.
Persino Carlo Collodi, nel 1886, testimonia dell’uso del pomodoro sulla pizza di Napoli, descrivendo quell’alimento agli scolari italiani nel suo Il viaggio per l’Italia di Giannettino – Parte terza: l’Italia meridionale:
“Vuoi sapere cos’è la pizza? È una stiacciata di pasta di pane lievitata, e abbrustolita in forno, con sopra una salsa di ogni cosa un po’. Quel nero del pane abbrustolito, quel bianchiccio dell’aglio e dell’alice, quel giallo-verdacchio dell’olio e dell’erbucce soffritte e quei pezzetti rossi qua e là di pomidoro danno alla pizza un’aria di sudiciume complicato che sta benissimo in armonia con quello del venditore.”
Il professor Grandi commette dunque un autogol citando il “pizza effect” circa la pizza. Il cosiddetto “pizza effect” è proprio il fenomeno sociologico per cui un elemento della cultura di un particolare popolo viene conosciuto e diffuso maggiormente in un altra nazione, e successivamente reimportato nella nazione del popolo che l’ha creato. E infatti la pizza con il pomodoro e la mozzarella, nata a Napoli nella prima metà dell’Ottocento, divenne ampiamente italiana solo oltre un secolo dopo, nel dopoguerra. Prima di allora, come dimostra lo scritto di Carlo Collodi, era considerata un alimento malsano da straccioni napoletani in odor di colera che lo preparavano per strada, discriminato come il popolo che lo mangiava. Poi, conosciuta dagli americani grazie agli emigranti napoletani che a inizio Novecento erano andati a farla negli States (il primo fu Gennaro Lombardi nel 1905, che sostituì la mozzarella con il formaggio locale), ne fu diffuso l’uso prima dai soldati americani impegnati sul fronte italiano per la Seconda Guerra Mondiale, che peraltro scoprirono il gusto originale a Napoli, e poi dai turisti statunitensi negli anni Sessanta, che la chiedevano nei ristoranti italiani negli anni del benessere economico. Come il fisiologo statunitense Ancel Keys, codificatore della Dieta Mediterranea, che assaggiò quella originale durante i suoi soggiorni a Napoli nei primi anni Cinquanta per osservare e studiare sul posto la virtuosa alimentazione locale, e provò ad ordinarla invano in un ristorante della vicina Roma. Raccontò lui stesso nei suoi scritti che la risposta fu: «Spiacenti, niente pizza qui, quella è roba da napoletani». A quei tempi, a Milano si diceva «Mi la pizza la mangi a Napoli e el pess el mangi al mar».
In conclusione, la pizza con pomodoro e mozzarella, creazione napoletana della prima metà dell’Ottocento, fu conosciuta dagli americani a inizio Novecento grazie agli emigranti napoletani, prima che la abbracciassero gli italiani negli anni Sessanta. Questa è storia.