Angelo Forgione – Il falso parto della pizza Margherita, quello del 1889, diviene sempre più oggetto di attenzione internazionale.
La prestigiosa testata americana National Geographic, tradotta in decine di lingue, si è interessata alla vicenda portata alla ribalta negli ultimi anni, a gran forza, dal sottoscritto ma non solo, mettendo in forte dubbio il romantico e folcloristico racconto dell’omaggio tricolore del pizzaiuolo Raffaele Esposito alla regina Margherita di Savoia. Braden Phillips, autore di un articolato scritto per la famosa rivista,, definisce “recenti ricerche” quelle che, condotte dagli “storici dell’alimentazione”, hanno individuato “diversi buchi-chiave nel racconto“. Nell’articolo si legge:
“Probabilmente il fatto più schiacciante è che il piatto esistesse almeno tre decenni prima della visita dei Savoia a Napoli”.
Phillips si riferisce alla descrizione delle pizze di Napoli fatta da Emmanuele Rocco negli anni Cinquanta dell’Ottocento in Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti, in cui si chiarisce che, ovviamente a Napoli, in una delle tante combinazioni di metà Ottocento almeno finivano “foglie di basilico”, “sottile fette di muzzarella” e “pomidoro”.
Una delle tante combinazioni di condimento, non la più gettonata. Rifacendomi alla ricerca scientifica Sull’alimentazione del popolo minuto in Napoli, pubblicata nel 1863 dai medici Achille Spatuzzi, Luigi Somma ed Errico De Renzi, ho chiarito in Il Re di Napoli come a quel tempo fosse una pizza preparata soprattutto d’estate, non essendoci l’industria delle conserve di pomodoro:
“I Napoletani mangiano a dovizia le pizze: (…) condite (…) con pomidoro specialmente in està (…)”.
Le “recenti ricerche” cui fa riferimento Phillips sono quelle dalle quali ho poi chiarito che la pizza di Napoli, nei primi decenni unitari del Regno d’Italia, era considerata un cibo da sudici straccioni napoletani, come si evince dalla descrizione che ne diede agli scolari italiani Carlo Collodi nel 1886, definendola un “sudiciume complicato che sta benissimo in armonia con quello del venditore”.
Esistevano già le prime pizzerie, con tanto di tavoli, sedie e stoviglie, ma le pizze erano ancora vendute nelle strade di Napoli dai venditori ambulanti, a lungo infamati come pure ciò che proponevano e anche l’ingrediente che li imparentava alla pasta, il pomodoro, per anni considerato un segno di una meridionalità rozza e popolana. Dunque, l”italianizzazione” della pizza, tipica di Napoli, nascondeva il duplice scopo di creare affezione verso la Casa Reale e di restituire dignità al cibo di strada napoletano, danneggiato nella reputazione dalle diverse epidemie coleriche, soprattutto quella del 1884, di cui era divenuto, per molti timorosi, veicolo di contagio. I Savoia, che non potevano permettersi di trascurare i problemi sanitari di Napoli, la città più popolosa d’Italia, con la Legge per il Risanamento, fecero realizzare un più sicuro sistema fognario e un nuovo acquedotto, quello del Serino, garanzia di salubrità dell’acqua e della sicurezza alimentare. Almeno di un po’ di simpatia dovevano ricevere in cambio, attraverso l’associazione della pizza alla regina Margherita.
Braden Phillips scrive esattamente di operazione simpatia nel suo articolo per il National Geographic, e avanza la teoria della falsificazione della lettera di ringraziamento di Sua Maestà la Regina indirizzata a Raffaele Esposito Brandi, seguendo quanto ho scritto ne Il Re di Napoli di seguito riportato:
“(…) un documento pieno di incongruenze, dal quale si dovrebbe dedurre che il pizzaiuolo, sposando Maria Giovanna Brandi, ne avrebbe preso il cognome. Più facile che quel documento sia stato scritto in maniera fittizia, con timbri fasulli, dopo gli anni Venti del Novecento, quando la pizzeria in cui aveva lavorato Raffaele Esposito cambiò nome in Brandi, così da blindare l’invenzione di una tradizione apocrifa.”
Insomma, un racconto anche grazie al quale la pizza tricolore è divenuta la pizza regina, passando da Napoli a New York con gli emigranti, e solo dopo la guerra nel resto d’Italia e del mondo. Un racconto cavalcato dai discendenti di Maria Giovanna Brandi per aumentare l’appeal della pizzeria e gli affari. Se ne sono convinti anche quelli di National Geographic, dimostrandoci che la ricostruzione della storia della pizza tricolore ha ormai varcato i confini nazionali e si espande… a macchia d’olio.
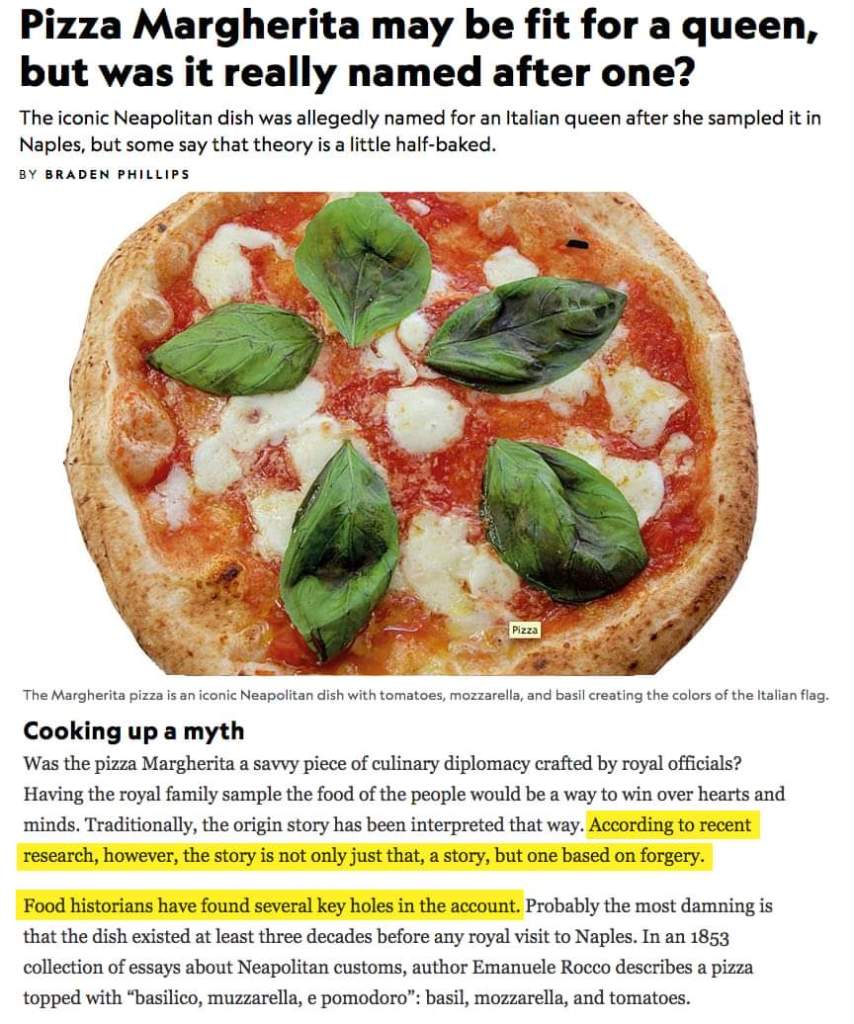



 Angelo Forgione
Angelo Forgione



 Rinasce la Real Tenuta di Carditello! Nella mattinata di sabato 29 ottobre la piccola reggia borbonica in tenimento di San Tammaro, riacquistata dallo Stato grazie all’interessamento dell’ex ministro dei beni culturali Massimo Bray, riaprirà al pubblico, dopo un primo restauro durato un anno e mezzo che ha riedificato l’immagine complessiva del sito assicurando un primo livello di fruizione. Nel galoppatoio antistante l’edificio centrale andrà in scena lo spettacolo “Cavalli e Cavalieri”, esibizione equestre in tre momenti: una rievocazione storica sul cavallo Persano a Carditello nel XVIII secolo, un saggio d’alta scuola italiana e delle esibizioni del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo con fanfara.
Rinasce la Real Tenuta di Carditello! Nella mattinata di sabato 29 ottobre la piccola reggia borbonica in tenimento di San Tammaro, riacquistata dallo Stato grazie all’interessamento dell’ex ministro dei beni culturali Massimo Bray, riaprirà al pubblico, dopo un primo restauro durato un anno e mezzo che ha riedificato l’immagine complessiva del sito assicurando un primo livello di fruizione. Nel galoppatoio antistante l’edificio centrale andrà in scena lo spettacolo “Cavalli e Cavalieri”, esibizione equestre in tre momenti: una rievocazione storica sul cavallo Persano a Carditello nel XVIII secolo, un saggio d’alta scuola italiana e delle esibizioni del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo con fanfara.

