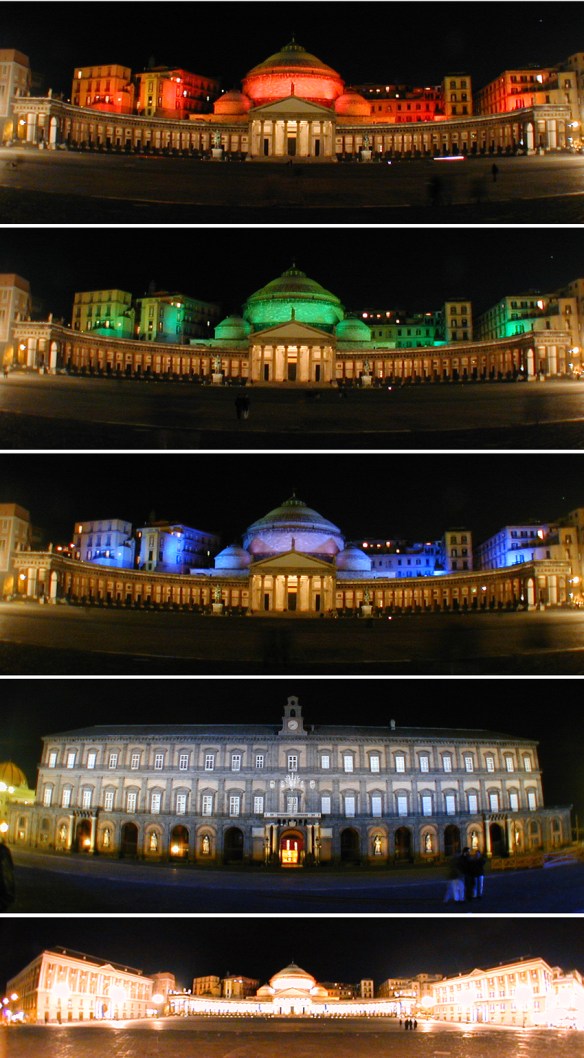Antonio Joli – Porta dello Spirito Santo prima della demolizione
 Angelo Forgione – A metà del Seicento, alla vigilia dall’implacabile peste, Napoli, con i suoi circa 300.000 abitanti, risultò la più popolosa città d’Occidente. L’incremento demografico fu stimolato dalle primissime estensioni attuate nel Cinquecento dal viceré spagnolo Pedro de Toledo, che attirò l’aristocrazia in città assicurandogli l’esenzione di alcune tasse, sradicandola così dalle sedi feudali, con lo scopo di addomesticarla e tenerla sotto controllo.
Angelo Forgione – A metà del Seicento, alla vigilia dall’implacabile peste, Napoli, con i suoi circa 300.000 abitanti, risultò la più popolosa città d’Occidente. L’incremento demografico fu stimolato dalle primissime estensioni attuate nel Cinquecento dal viceré spagnolo Pedro de Toledo, che attirò l’aristocrazia in città assicurandogli l’esenzione di alcune tasse, sradicandola così dalle sedi feudali, con lo scopo di addomesticarla e tenerla sotto controllo.
Il “viceré urbanista”, al suo arrivo nel 1532, per migliorare l’aspetto della città, concepì un piano di sventramento, allargamento e fortificazione, e dispose la demolizione della murazione aragonese per farne alzare una nuova, con perimetro ben più allargato, coinvolgendo nello sviluppo urbano le pendici collinari. Il progetto ebbe nella nuova strada di Toledo uno dei cardini principali, realizzata nel 1536 per bonificare il Chiavicone, la fogna ad alveo aperto che da Montesanto che, convogliando le acque reflue e i liquami della collina del Vomero, proseguiva verso il mare, e per collegare agevolmente la vecchia città alla nuova residenza vicereale, che poi sarebbe stata demolita nel 1600 per fare spazio al nuovo Palazzo Reale di Domenico Fontana. La nuova strada, sul cui declivio della collina di San Martino furono edificati i nuovi quartieri militari, fu un vero successo e fu ben accolta dalla cittadinanza.
L’asse stradale venne iniziato da una porta edificata nel 1538 tra il Mercatello (attuale piazza Dante) e il largo dello Spirito Santo, segnando un nuovo ingresso in città da nord e dall’area collinare. Fu chiamata Porta Reale Nuova, per differenziarla dalla vecchia di età angioina, che era sita nella zona dove oggi si trova il liceo Genovesi. Sulla porta, semplice nella sua fattura, sul lato del Mercatello, fu apposta l’aquila bicipite di Carlo V d’Asburgo, sotto le cui ali erano lo scudo del viceré e un altro di dubbia decifrazione, e un’epigrafe latina che segnalava l’operato di Don Pedro. La costruzione fu in seguito abbellita da sculture e da una statua di San Gaetano da Thiene, accolto a Napoli nel 1533 proprio da Don Pedro, che gli concesse la basilica di San Paolo Maggiore, e morto in città nel ’47. In seguito alla costruzione della basilica dello Spirito Santo, nel 1562, la nuova porta fu riconosciuta anche come Porta dello Spirito Santo.
La murazione toledina fu abbattuta nel Settecento, inizialmente da Carlo di Borbone per la costruzione della nuova strada di Marina, e poi dall’erede Ferdinando per il nuovo Foro Carolino al largo del Mercatello e il largo delle Pigne (piazza Cavour). Il giovane Re, nel 1775, fece buttare a terra anche la Porta Reale, ormai fatiscente e di intralcio al traffico, e gli edifici attigui, allineati in asse con la strada di Toledo. Con l’incremento dell’Avvocata e il completamento del Foro Carolino, l’emiciclo vanvitelliano con cui fu sistemato il Mercatello, la porta divenne un imbuto d’intralcio alla vista prospettica della strada e al passaggio, soprattutto a tarda sera, al ritorno dalle passeggiate, orario in cui il popolo era costretto ad attendere per molto tempo il passaggio delle carrozze e infilarvisi con gran ressa. La statua di San Gaetano fu spostata all’apice della risistemata e ampliata Port’Alba e nel luogo della demolizione, sulla facciata di un palazzo all’ingresso di via Toledo, all’altezza dei civici 4 e 6, fu apposta una targa coronata dallo stemma cittadino che ricordava in latino l’atto sancito dagli uomini preposti alle mura e agli acquedotti, mentre più a destra, sul palazzo Pedagna, era possibile notare la lapide d’epoca vicereale prima sulla porta demolita e anche un’iscrizione d’epoca angioina in caratteri gallo-franchi, in ricordo della più antica porta abattuta nel Cinquecento.
Se vi inoltrate per via Toledo da piazza Dante alzate gli occhi. Le tracce di questo piccolo frammento di storia napoletana sono ancora lì.