 Angelo Forgione – Tra gli ideali che ispirarono l’Unità italiana, quello laicista fu sicuramente uno dei più importanti. Rifacendosi alle più avanzate nazioni protestanti europee, gli artefici dell’annessione di Napoli e Roma al Regno d’Italia piemontese dovevano rendersi protagonisti della diffusione di un’ideologia svincolata dalla fortissima tradizione cattolica d’Italia, e contribuire ad allentare lo stretto rapporto con la Chiesa di Roma che aveva sempre caratterizzato la vita degli stati italiani.
Angelo Forgione – Tra gli ideali che ispirarono l’Unità italiana, quello laicista fu sicuramente uno dei più importanti. Rifacendosi alle più avanzate nazioni protestanti europee, gli artefici dell’annessione di Napoli e Roma al Regno d’Italia piemontese dovevano rendersi protagonisti della diffusione di un’ideologia svincolata dalla fortissima tradizione cattolica d’Italia, e contribuire ad allentare lo stretto rapporto con la Chiesa di Roma che aveva sempre caratterizzato la vita degli stati italiani.
A preservare l’autorità del Papa ci pensò un francese, non un italiano. Napoleone III, imperatore di quella Francia “figlia primogenita della Chiesa” piena di cattolici e di un consenso da preservare, piazzò le sue truppe in territorio romano mentre il Piemonte incamerava parte dello Stato Pontificio, e fu un bel problema per Garibaldi ma anche per la pletora sabauda. Vi era bisogno di tutta la scaltrezza piemontese per risolvere la rogna, anche perché la posizione geografica di Torino, troppo vicina al confine nemico, la condannava a non essere per troppo tempo la capitale d’Italia. Le trattative diplomatiche portarono alla Convenzione di settembre del 1864, con cui il Re di Francia si impegnò a ritirare gradualmente i suoi uomini in cambio dell’impegno a non invadere il territorio pontificio. A garanzia degli impegni presi dai piemontesi, il sovrano francese impose il trasferimento della capitale in un’altra città, cosa che avrebbe dovuto provare la definitiva rinuncia alle seducenti mitologie di Roma capitale dell’Italia laica. I piemontesi miravano semplicemente a far sloggiare i garanti di Pio IX, per poi rompere i patti alla loro maniera. C’era solo da rinunciare in anticipo ai ministeri di Torino, alle ambasciate e ai fiumi di danaro pubblico, e da affrontare la rivolta dei cittadini torinesi, convinti che in assenza di Roma dovesse farne le veci solo la loro città, ormai pienamente interessata dagli investimenti per l’edilizia espansiva. Sommossa repressa nel sangue di cinquantacinque uomini disarmati, ma ormai tutto era già deciso: la capitale doveva trasferirsi altrove. Furono proposte Firenze, sostenuta dal Consiglio dei generali perché non esposta all’aggressione marittima, e Napoli, preferita dal consiglio dei ministri in quanto maggior metropoli italiana, lontana dal confine e meno esposta a un eventuale intervento austriaco richiesto dal Papa, ex capitale rispettata in Europa, la terza più popolata del Continente e già pronta a ricevere i dicasteri senza necessità di grandi spese, città di cultura degna delle grandi capitali europee. Tale scelta, secondo i sostenitori dell’ipotesi, avrebbe potuto contribuire a sradicare il brigantaggio meridionale che metteva a rischio la compattezza geografica. Prevalse la piccola Firenze, ma la volontà fu più che altro sovrana. Vittorio Emanuele II sapeva quanto fosse rilevante il peso di Napoli agli occhi dell’Europa e cercò di evitare che tornasse capitale. Il Re, invitato ad esprimere il suo pesante parere ai ministri, indirizzò la scelta verso la città toscana:
«Andando a Firenze, dopo due anni, dopo cinque, anche dopo sei se volete, potremo dire addio ai fiorentini e andare a Roma; ma da Napoli non si esce; se vi andiamo, saremo costretti a rimanerci. Volete voi Napoli? Se ciò volete, badate bene, prima di prendere la risoluzione di andare a stabilire la capitale a Napoli, bisogna prendere quella di rinunziare definitivamente a Roma.»
Tutti a Firenze! Una città di poco più di centomila abitanti invasa dalle istituzioni, dal Parlamento, dal Re, dalla corte e di tutto ciò che necessitava una capitale. Trentamila burocrati piemontesi a sconvolgerne le abitudini, le tradizioni e l’urbanistica. Ma gli uomini del “Re Galantuomo”, che gli accordi li prendevano per romperli, attesero che Roma fosse defrancesizzata e, dopo cinque anni e mezzo, invasero lo Stato Pontificio. Pio IX si ritirò in Vaticano, dichiarandosi “prigioniero d’Italia” fino alla morte, e si rifiutò di riconoscere la legge delle Guarantiglie, con cui il Regno d’Italia dei Savoia intese regolare i rapporti con la Santa Sede. Il Pontefice vietò ai cattolici di partecipare all’attività politica italiana e scomunicò tutti coloro che avevano partecipato al processo risorgimentale, a partire dai Savoia, ma si trovò di fronte l’ambigua figura di Vittorio Emanuele II, ricorso ai poteri forti d’Europa e alla Massoneria internazionale per coronare l’unificazione nazionale anche contro il Cattolicesimo, nonostante fosse riconosciuto religione di Stato dall’articolo 1 dello Statuto Albertino del Regno di Sardegna, poi esteso all’Italia unita. Pio IX scomunicò il primo re d’Italia per ben tre volte lungo l’arco della sua trono tricolore, ma ritirò il provvedimento nel 1878, in punto di morte del baffuto piemontese, inviando un sacerdote al suo capezzale per impartirgli l’assoluzione, poiché il primo sovrano dello stato nazionale italiano, comunque cattolico, non poteva e non doveva morire senza sacramenti.
Il Vaticano e l’Italia restarono separati in casa fino all’avvento del Fascismo, nel primo Novecento, mentre a rappresentare il rafforzato potere laico contrapposto alle forze conservatrici e clericali ci pensò la Massoneria. Il Potere temporale fu in qualche modo riabilitato dai negoziati tra Benito Mussolini e Pio XI, culminati nei Patti Lateranensi, con cui fu siglato un reciproco riconoscimento tra Regno d’Italia e Stato Vaticano. Fallita sul nascere la creazione di un Paese condiviso e giusto, naufragava anche lo scopo fondante di sradicare la sua appartenenza religiosa.





 21 ottobre 1860. 155 anni fa, con il plebiscito, si sanciva l’annessione di mezza Italia alle province del Regno di Sardegna. Votò meno del 20% dei meridionali (il resto era sotto assedio), con espressione palese che prefigurava conseguenze per chi si fosse diretto verso l’urna del NO. Numerosi furono gli episodi di minacce e incidenti, come risulta dai documenti della Polizia del tempo. Le cronache di allora narrano che alle urne si recarono anche più volte garibaldini, stranieri, donne e bambini, che non rappresentavano i reali sentimenti del territorio. Con il falso consenso popolare, Torino si estendeva fino a Portopalo di Capopassero, nella lontana “affrica”. Lo Statuto Albertino dei Savoia veniva applicato a tutta l’Italia (
21 ottobre 1860. 155 anni fa, con il plebiscito, si sanciva l’annessione di mezza Italia alle province del Regno di Sardegna. Votò meno del 20% dei meridionali (il resto era sotto assedio), con espressione palese che prefigurava conseguenze per chi si fosse diretto verso l’urna del NO. Numerosi furono gli episodi di minacce e incidenti, come risulta dai documenti della Polizia del tempo. Le cronache di allora narrano che alle urne si recarono anche più volte garibaldini, stranieri, donne e bambini, che non rappresentavano i reali sentimenti del territorio. Con il falso consenso popolare, Torino si estendeva fino a Portopalo di Capopassero, nella lontana “affrica”. Lo Statuto Albertino dei Savoia veniva applicato a tutta l’Italia (
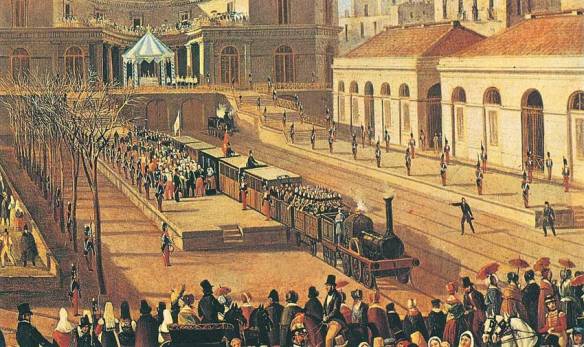

 Angelo Forgione
Angelo Forgione